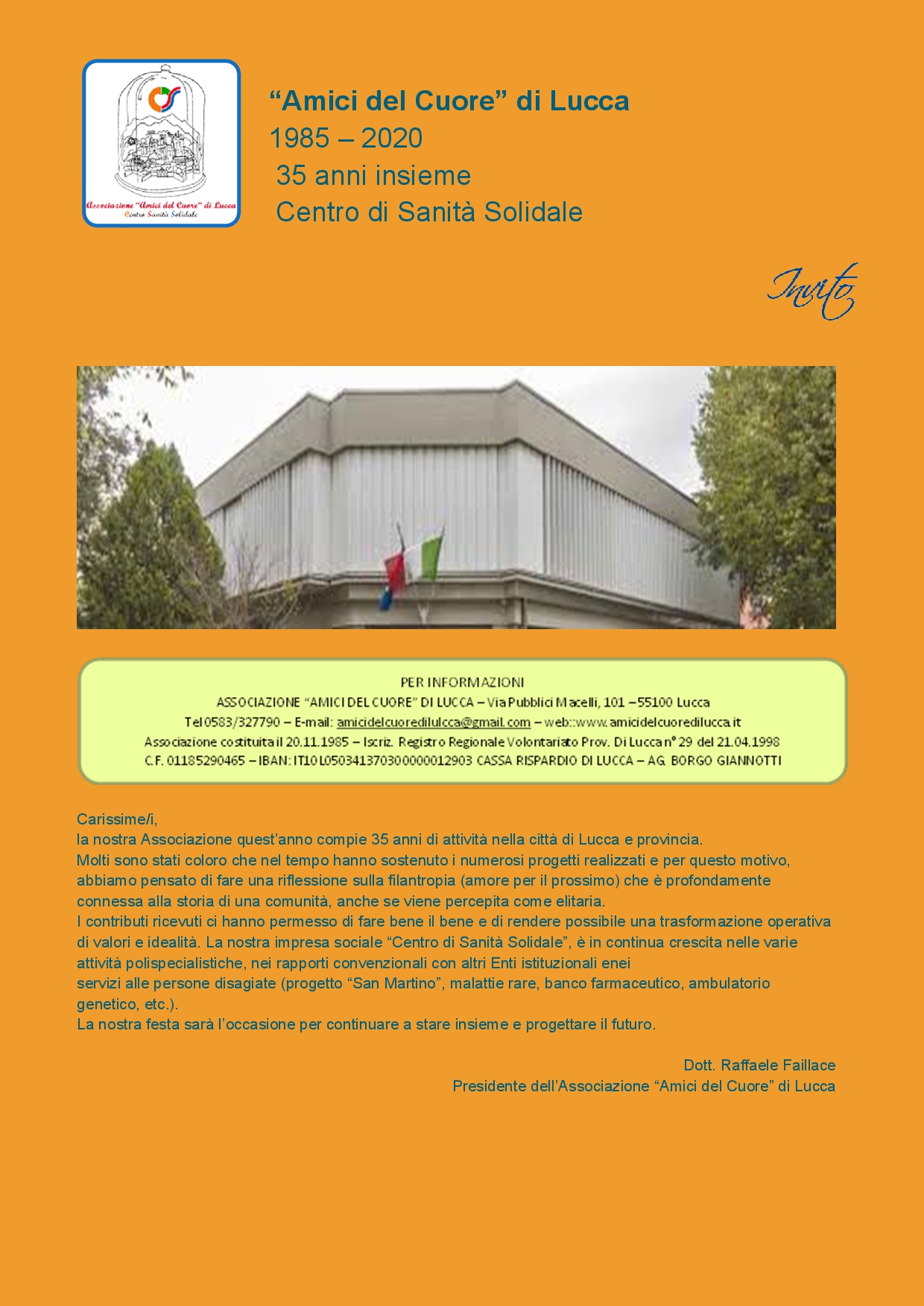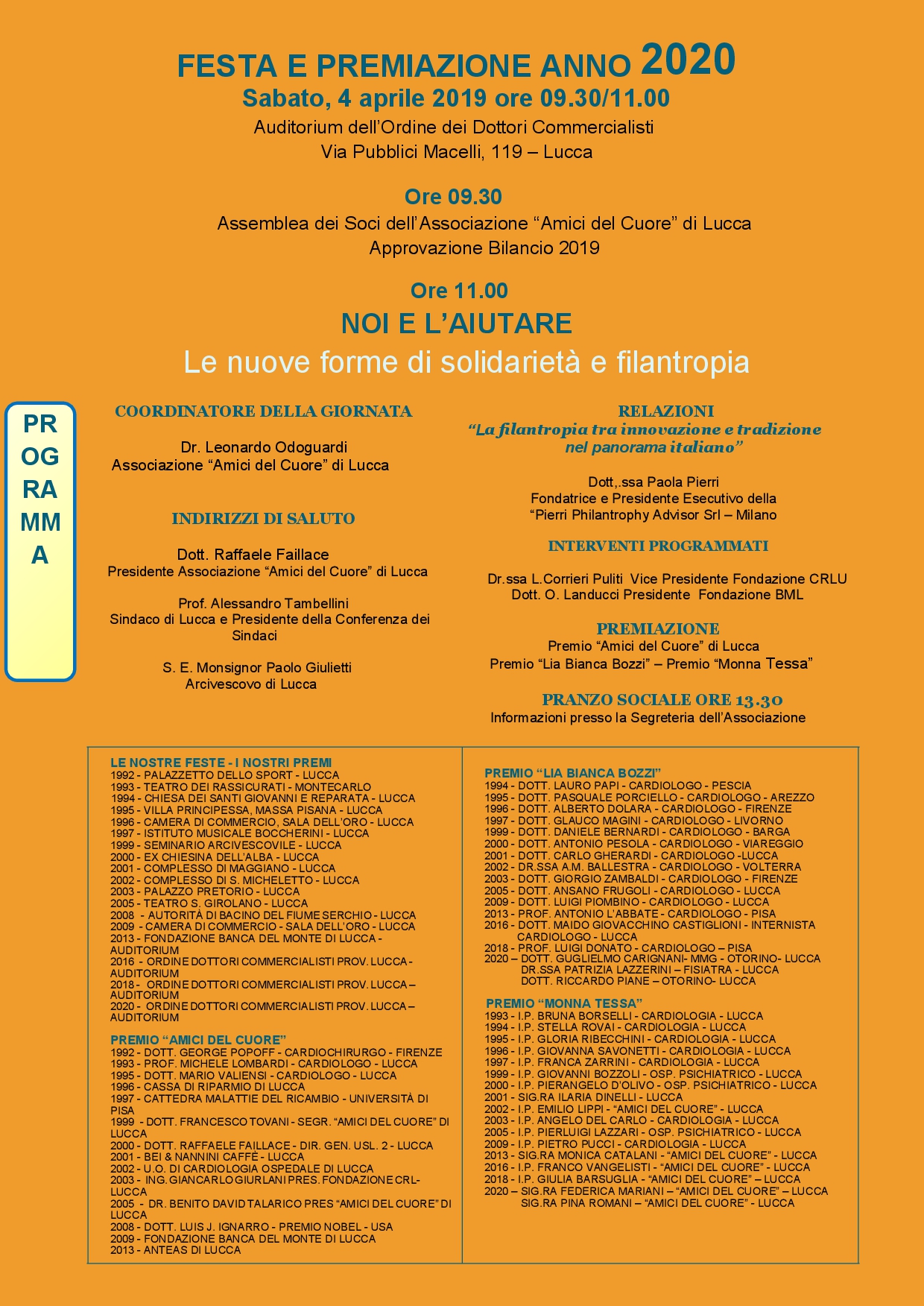Da oggi presso il nostro Centro ci prendiamo cura anche degli occhi dei più piccoli, a cura del dott. Chimenti.
L’ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”, è una condizione che interessa il 4% della popolazione mondiale ed è caratterizzata da una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio o, più raramente, di entrambi. In breve si può dire che dipende da un’alterata trasmissione del segnale nervoso tra l’occhio e il cervello per cui il cervello privilegia un occhio a causa della ridotta acuità visiva dell’altro. Allo stato delle conoscenze attuali può essere trattata con possibilità di successo più o meno completo solo entro i primi 5-6 anni di vita.
Che cos’è l’ambliopia?
Più frequentemente monolaterale, l’ambliopia può essere determinata da patologie oculari che, durante lo sviluppo dell’apparato visivo in età infantile (0-6anni), impediscono allo stimolo luminoso di raggiungere la retina (per esempio la cataratta in età pediatrica, molto spesso congenita).Nella maggioranza dei casi, però, si presenta in occhi perfettamente integri dal punto di vista anatomico. In questi occhi risulta alterata la corretta stimolazione sensoriale dell’apparato visivo, molto spesso a causa di difetti di refrazione non corretti.
Quali sono le cause dell’ambliopia?
Le cause più comuni dell’ambliopia sono:
Lo strabismo, cioè un anomalo allineamento degli occhi, provocato da un difetto dei meccanismi neuro-muscolari che ne controllano i movimentiCataratta congenita e ptosi palpebraleAnisometropia, cioè una differente refrazione tra i due occhiQuali sono i sintomi dell’ambliopia?
I segnali e i sintomi dell’occhio pigro sono molto raramente riferiti dal paziente perché è spesso troppo piccolo per denunciare una vista inferiore in un occhio rispetto all’altro. E’ per questo motivo che si raccomanda di effettuare una prima visita oculistica al bambino, anche in assenza di sintomi, entro i 3-4 anni di età.Attualmente vi è la tendenza ad anticipare ulteriormente la prima visita così che venga effettuata entro il primo anno di vita.Anche se l’occhio pigro colpisce solitamente solo un occhio, esiste la possibilità che interessi entrambi gli occhi.
Diagnosi
Gli esami per la diagnosi di ambliopia sono:
Visita oculisticaValutazione ortottica con studio della motilità oculareTrattamenti
La terapia anti-ambliopica va impostata il più presto possibile in stretta collaborazione con gli ortottisti. Il primo intervento, dopo una corretta valutazione e correzione dei difetti refrattivi e/o delle cause che anatomicamente impediscono la corretta proiezione sulla retina delle immagini provenienti dall’ambiente esterno (come cataratta o ptosi palpebrale), consiste nell’occlusione diretta con bende adesive applicate sull’occhio o sull’occhiale e/o con filtri semitrasparenti posti sugli occhiali.
Prevenzione
Per combattere l’ambliopia è fondamentale la diagnosi precoce e il conseguente trattamento tempestivo. L’arma migliore resta la prevenzione con visite di screening da effettuare già all’età di sei mesi e controlli periodici nel corso dei primi 5-6 anni di vita del bambino.





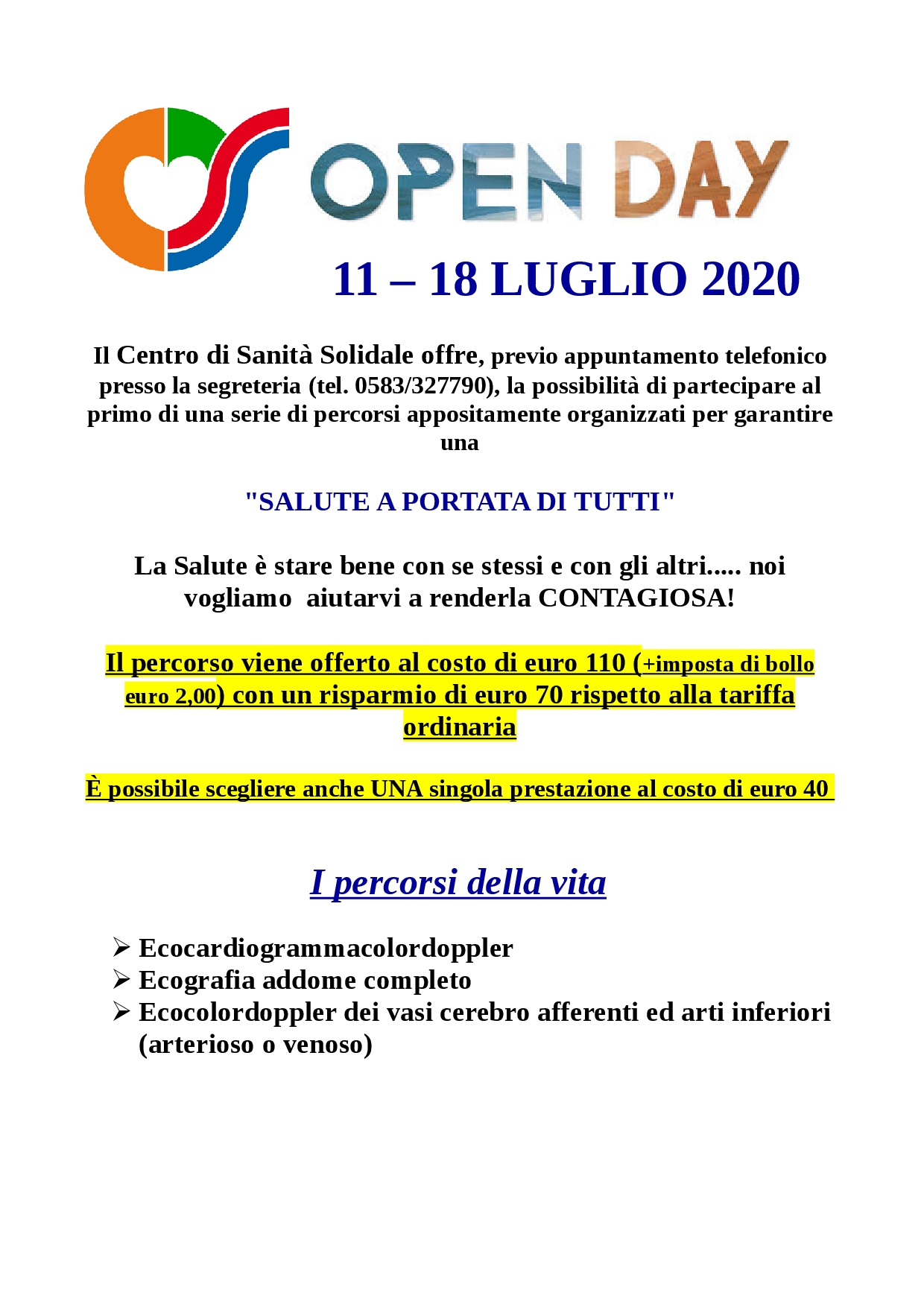

 riconosciuta all’interno del Modello Bio-Psico-Sociale nel quale non solo l’esperienza del dolore,come detto sopra, ma anche la malattia e la salute in generale vengono attribuite all’interazione intricata di fattori biologici, psicologici e sociali.
riconosciuta all’interno del Modello Bio-Psico-Sociale nel quale non solo l’esperienza del dolore,come detto sopra, ma anche la malattia e la salute in generale vengono attribuite all’interazione intricata di fattori biologici, psicologici e sociali. Fisiologicamente gli stimoli dolorosi sono recepiti da sensori presenti nel nostro corpo chiamati nocicettori; essi inviano segnali di potenziale pericolo dal corpo al
Fisiologicamente gli stimoli dolorosi sono recepiti da sensori presenti nel nostro corpo chiamati nocicettori; essi inviano segnali di potenziale pericolo dal corpo al capoufficio che può decidere cosa fare con il messaggio riportatogli dalla segretaria. Quest’ultimo può decidere per esempio che non vuole essere disturbato o che, in base a esperienze precedenti, il messaggio non è importante e pertanto può decidere di “mettere la chiamata in sospeso”.
capoufficio che può decidere cosa fare con il messaggio riportatogli dalla segretaria. Quest’ultimo può decidere per esempio che non vuole essere disturbato o che, in base a esperienze precedenti, il messaggio non è importante e pertanto può decidere di “mettere la chiamata in sospeso”.